GLI ACARI DELLA POLVERE |
Dott. R Muzzolon, Dott. A Sernagiotto, Dott. G. D'Ambros |
Divisione di Pneumolgia - U.L.S.S. n. 1 - Belluno |
GLI ACARI DELLA POLVERE |
Dott. R Muzzolon, Dott. A Sernagiotto, Dott. G. D'Ambros |
Divisione di Pneumolgia - U.L.S.S. n. 1 - Belluno |
Non si vedono, non si sentono, non pungono, ma sono con noi
a migliaia, a milioni. Sono gli Acari della polvere, una delle principali cause di
allergia respiratoria (nella Provincia di Belluno sono responsabili del 47 % della
patologia allergica respiratoria).
Che la polvere di casa contenesse allergeni che causano l'asma fu suggerito per la prima
volta nel 1921. Tuttavia, la relazione fra acari ed allergia alla polvere di casa venne
stabilita in modo definitivo solo nel periodo dal 1962 al 1969 grazie agli studi di
Voorhorst, Spieksma-Boezeman M.I.A. e Spieksman F.Th.M.
Gli acari sono fra gli esseri viventi più antichi sulla terra; essi possono vivere e
crescere in ambienti differenti come le piante, i fiori, gli animali, l'uomo, la terra,
sui laghi e sull'acqua salata, nelle case e nei rifiuti organici, nei materassi, nei libri
etc.
Gli acari sono piccoli artropodi, appartenenti a diverse specie. Le specie che sono in
modo particolare correlate all'asma sono collettivamente chiamate "acari della
polvere di casa", poichè hanno il loro habitat permanente nell'ambiente domestico.
Classificazione
Indice
Gli acari fanno parte del phylum degli artropodi in quanto
possiedono un esoscheletro ed hanno le appendici suddivise in articoli. Hanno piccole
dimensioni, circa 0,5 mm e la loro più cospicua caratteristica è una riduzione nella
segmentazione del corpo, proprietà fondamentale degli altri artropodi. Si distinguono
dagli insetti perché gli adulti possiedono otto zampe invece di sei. I tentativi per dare
alla Zoologia una buona classificazione degli acari sono numerosi e, pur essendo ancora
oggetto di controversia, possono essere classificati come segue:
ORDINE |
FAMIGLIA | GENERE | SPECIE |
| Pyroglyphus | africans | ||
| Euroglyphus | maynei | ||
| Pyroglyphydae | pteronyssinus | ||
| Dermatophagoides | farinae | ||
Astigmata |
microceras | ||
| Acarus | siro | ||
| Acaridae | Tyrophagus | putrescentiae | |
| Thyreophagus | entomophagus | ||
| Glycyphagidae | Glycyphagus | domesticus | |
| Lepidoglyphus | destructor |
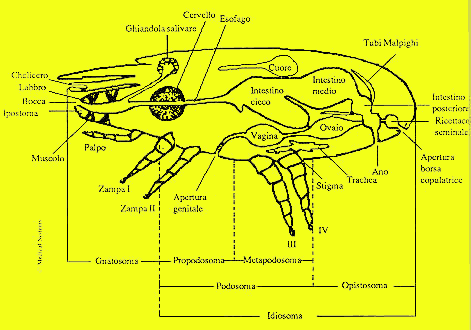
Le loro dimensioni sono di circa 200-300 micron, cioè
all'incirca 1/4 di millimetro, per cui non possono essere visti ad occhio nudo, ma
soltanto con una forte lente di ingrandimento o, meglio, al microscopio. Il maschio è
leggermente più piccolo della femmina.

La dura pelle chitinosa è translucida consentendo agli organi interni e all'emolinfa di
impartire un aspetto complessivamente bianco-cremoso al corpo, con qualche chiazza isolata
giallo pallido. Le aree sclerotizzate, quali le zampe e la testa degli adulti
completamente sviluppati, sono decisamente più pigmentate con un colore rosso-bruno che
spicca sul resto del corpo. L'aspetto più sorprendente ed esteticamente piacevole della
pelle è la presenza di un disegno scolpito che assomiglia a quello delle impronte
digitali.
L'acaro della polvere è privo di una vera testa; la parte anteriore del corpo o gnatosoma
funge da apparato buccale, oltre ad avere funzioni di presa e sensoriali.
|
|
Apparato buccale |
Tegumento |
Gli occhi sono assenti e nonostante non vi siano degli
evidenti recettori luminosi, gli acari della polvere sono estremamente fotofobici e
diventano molto animati alla ricerca di recessi bui quando sono esposti alla luce.
Riproduzione
Indice
Gli acari sono a sessi separati; il dimorfismo sessuale è spesso accentuato ed anche se
vi sono alcune eccezioni, la riproduzione è per via sessuale. Gli organi sessuali possono
presentare strutture assai complesse, specialmente nei maschi, in cui si riscontra sempre
la presenza di un organo detto pene, di forma diversa nelle differenti specie. Il pene nel
caso più semplice ha la forma di un cilindretto protetto durante il riposo da una guaina
membranosa.
|
|
Organi genitali maschili |
Organi genitali femminili |
L'apertura genitale femminile (vagina) è in posizione
ventrale ed assume la funzione di organo adibito alla deposizione delle uova (ovoporo). La
vagina tramite l'utero quando esiste, assieme alle ovaie, comunicano con la borsa
copulatrice, che è posta ventralmente, o, come negli Astigmati, dorsalmente al di sopra
dell'ano. La borsa copulatrice è costituita dal vestibolo o apertura della borsa
copulatrice, da un sottile canale e dal ricettacolo seminale. Il vestibolo si apre
all'esterno e tramite il canalicolo comunica con il ricettacolo seminale. Il maschio
attratto da ferormoni prodotti dalla femmina, durante l'accoppiamento depone lo sperma nel
vestibolo della femmina. Lo sperma raggiunge il ricettacolo seminale e da qui le ovaie
dove feconda le uova, che giunte a maturazione vengono deposte una per volta ed in un
numero variabile da specie a specie. Dalle uova dopo alcuni giorni escono le larve
esapode, che attraverso varie mute si trasfomano in ninfe ottopodi: protoninfa,
deutoninfa, tritoninfa ed adulto .
In alcuni acari fra lo stadio di protoninfa e di tritoninfa s'intercala uno stadio
eteromorfo detto hypopus. Esistono due forme di hypopus: una attiva dotata di movimenti,
che si attacca ad altri artropodi, mammiferi, uccelli e da essi viene trasportata,
consentendo la diffusione della specie; una inerte che è alquanto o completamente priva
di movimenti, frequentemente rimane racchiusa nella cuticola della protoninfa e può
essere trasportata dal vento. L'hypopus rappresenta uno stadio di sviluppo che è in grado
di resistere a condizioni ambientali sfavorevoli, come bassa umidità e relativa assenza
di nutrimento, per settimane o mesi, per poi riprendere il suo sviluppo normale quando
cessano le avverse condizioni. L'hypopus inerte si forma in alcuni acari del genere
Acarus, Glycyphagus, Lepidoglyphus,ecc.
L'intero ciclo da uovo ad adulto si compie in 2-3
settimane. Gli adulti hanno una vita media di 2-4 mesi (circa 80 giorni per i maschi e 160
giorni per le femmine di dermatofagoidi); durante questo periodo di vita hanno uno o due
accoppiamenti, dopo i quali la femmina depone complessivamente 20-50 uova.
L'acaro della polvere può tollerare un'ampia variazione di temperatura da circa 0 gradi
centigradi sino a circa 30 gradi, con l'optimum attorno ai 20-25 gradi. L'umidità
ambientale è più importante della temperatura, e c'è una ridotta tolleranza alle
variazioni : l'optimum di umidità relativa è attorno al 75% con uno scostamento massimo
di +/- 10%. Mentre la maggior parte delle abitazioni a riscaldamento centralizzato con
tutta probabilità mantiene una temperatura ideale costante, l'umidità relativa è
generalmente inferiore al 65% rendendo questo tipo di abitazioni meno attraenti per
l'acaro di quanto sia generalmente ritenuto.
Va ricordato, comunque, che gli acari sono molto resistenti anche a condizioni disagiate,
per cui sono stati ritrovati anche in alta montagna (fino a quote di 4500 metri,
soprattutto in condizioni di temperatura e di umidità relativamente elevate) ed in
regioni polari (Groenlandia, Antartide). Si è visto, ad esempio, che per sterminare il
D.farinae è necessaria un'esposizione protratta per almeno 48 ore a -18°C, mentre per
eliminare il D. pteronyssinus occorre un'esposizione di almeno 6 ore a -50°C .
Distribuzione
Indice
Gli acari si sviluppano in quei luoghi della casa che forniscono loro una sorgente di cibo
e riparo, come i tappeti e i materassi.La struttura fibrosa e cellulare di questi ambienti
permette agli acari di accumulare acqua e ridurne le perdite.Lo sviluppo numerico dei
Dermatofagoidi nelle polveri domestiche risente notevolmente dei fattori
igienico-ambientali e climatici, per cui varia in maniera considerevole la loro
concentrazione nella polvere nelle diverse abitazioni ed anche nei singoli ambienti di una
stessa abitazione (in linea di massima, comunque, si ritrovano maggiormente nelle camere
da letto). Le concentrazioni di Dermatofagoidi possono, quindi, variare da 10 a 1000 e
più per ciascun grammo di polvere.
Acari minori.
Accanto al Dermatophagoides pteronissynus e D.
farinae (cosiddetti "acari maggiori" perchè responsabili della maggior
parte delle manifestazioni allergiche) vi sono moltissime specie di acari minori
(così detti in quanto costituiscono, in genere, meno del 10% della popolazione acaridica
totale delle polveri domestiche), alcune delle quali sono dotate di attività allergenica.
Di questi acari minori, molti dei quali sono i cosiddetti "acari delle derrate"
("storage mites"), i più importanti dal punto di vista allergologico sono:
• Acarus siro ("acaro delle farine"), il cui habitat preferenziale è
rappresentato da farine e da cereali, per cui è di costante rinvenimento neimulini e nei
silos, oltre che dalla crosta dei formaggi, su cui forma spesso una caratteristica
polverina bianca, la cosiddetta "camola".
• Lepidoglyphus destructor, che si ritrova soprattutto nei fienili, nei granaie, in
genere, negli ambienti dove si conservano derrate alimentari (salumi, cereali, etc.). Una
delle sue caratteristiche è la capacità di resistere a basse temperature.
• Tyrophagus putrescentiae, presente, in particolare, nei prosciutti, per cui viene
anche chiamato "acaro del prosciutto crudo". Si rinviene in grande quantità nei
locali adibiti alla stagionatura dei prosciutti, ma anche nei caseifici (un altro habitat
è costituito dal formaggio), nei magazzini e nei negozi di alimentari, nei silos (in
quanto può infestare grano ed altri cereali), nelle coltivazioni di funghi, etc.
• Glycyphagus domesticus, che deve il suo nome al fatto che predilige per la sua
alimentazione le sostanze zuccherine, per cui è di frequente riscontro nei prodotti
dolciari, ma anche nei formaggi, nel grano e nelle farine e, quindi, si ritrova nei negozi
di alimentari e nelle cucine delle abitazioni. E' curioso ricordare che questo acaro si
sposta da un luogo all'altro con grande velocità rispetto ad altri acari, per cui viene
definito "acaro sportivo".
• Gohieria fusca, presente nelle derrate alimentari ed in vari cereali. Deveessere
rilevato che è l'unico acaro minore che si ritrova nei materiali letterecci (materassi,
cuscini, etc.) e di imbottitura, oltre che nelle sedie impagliate.
Alimentazione
Indice
La dieta degli acari consiste di
-scaglie di pelle umana
-funghi che crescono sulla pelle umana
-muffe
-corpi e frammenti di insetti (ad es. scarafaggi)
-granuli pollinici
-batteri
-polvere domestica che contiene quanto sopra
Digestione
Indice
L' Apparato digerente è costituito da tre parti: a) intestino anteriore che comprende la
faringe e l'esofago, deriva dallo stomodeo e quindi dall'ectoderma. b) intestino medio che
si suddivide in intestino tenue anteriore e posteriore. Da esso di originano dei
diverticoli ciechi; la sua derivazione embrionale è endodermica. e) intestino posteriore
o terminale che comprende l'intestino terminale anteriore e l'intestino terminale
posteriore.Quest'ultimo sbocca all'esterno tramite l'ano, situato nella parte ventrale e
posteriore dell'opistosoma, raramente è terminale. L'origine dell'intestino posteriore è
ectodermica. Alcuni acari sono privi di ano e quindi l'intestino posteriore è cieco, per
cui l'alimento viene digerito ed assorbito senza espulsione di residui fecali. La
digestione è intracellulare, almeno nella parte anteriore dell'intestino tenue. Brody ha
notato che nel Dermatophagoides farinae può avvenire una digestione extracellulare a
livello dell'intestino tenue posteriore, dove il bolo alimentare viene avvolto da una
delicata membrana epiteliale detta membrana peritrofica. Il bolo così ricoperto si muove
verso l'intestino tenue posteriore e viene espulso dall'ano sotto forma di pallottole
fecalidi diametro 10-40 micron.
Fisiologia della produzione
degli allergeni
Indice
Esistono diverse vie attraverso cui gli acari possono secernere ed espellere sostanze
IgE-leganti: deposizione uova; secreti delle ghiandole della muta e di quelle genitali;
enzimi digestivi e guanina contenuti nelle feci.
Attualmente sembra che non vi siano prove che le uova possano essere una fonte di
allergeni della polvere. Le secrezioni ghiandolari come sorgente di allergeni sono un
aspetto della chimica delle secrezioni che deve essere ancora studiata con maggior
approfondimento. Chapman nel 1980-82 purificò un allergene del D.pt di natura
glicoproteica e lo chiamò antigene P. Tovey et al nel 1981 stabilirono che tale antigene
è presente in grande quantità nelle feci degli acari, e che il 75% delle IgE dei sieri
di persone allergiche al D.pt, erano dirette contro questo allergene, classificato come
allergene maggiore. Si ritiene che nella polvere ambientale si possano rinvenire fino a
100.000 particelle fecali/grammo di polvere; una certa quantità di queste particelle,
variabile soprattutto a seconda della ventilazione, è aerosospesa e può essere inalata.
Oltre l'80% degli allergeni degli acari si ritrova in particelle aerotrasportate di
diametro superiore a 10 micron.
A questo punto veniva posta la domanda relativa alla sorgente ed al meccanismo di
formazione di questo allergene. Le ipotesi avanzate sono state: un prodotto della
digestione del cibo; una sostanza sintetizzata nel tratto gastrointestinale; un prodotto
di escrezione secreto nel canale alimentare.
Thompson nel 1988 ha cercato di rispondere a queste ipotesi giungendo a queste
conclusioni: le particelle fecali non contengono Der P 1 fino al 14° giorno del ciclo
vitale dell'acaro, quindi l'ipotesi che esso sia un prodotto della digestione del cibo
veniva a cadere. La seconda ipotesi era la più attendibile, anche perché Stewart aveva
dimostrato mediante reazioni con anticorpi fluorescenti, che questi allergeni erano
contenuti nelle cellule dello stomaco. I fattori che controllano la sintesi e la
secrezione di questa sostanza di natura enzimatica, non sono tuttavia ancora conosciuti.
Ecologia
Indice
Studi sulla distribuzione geografica e stagionale degli acari in vari ecosistemi della
casa, ha dimostrato che i Piroglifidi sono ubiquitari. Nella casa essi si trovano in varie
nicchie, tra cui: sistema letto, tappeti, divani, poltrone, mobili imbottiti e vestiario.
In questi ecosistemi gli acari trovano le condizioni ambientali idonee alla loro vita:
temperatura, Umidità Relativa, presenza di nutrimento rappresentato dalla desquamazione
della cute umana e residui di alimenti. Il numero di acari infestanti è maggiore nei
centri rurali che nelle zone urbane, in zone tropicali rispetto a quelle temperate.
In questi ultimi 50 anni sono avvenuti parecchi cambiamenti nella costruzione e
nell'arredamento delle case dei paesi più ricchi, che avrebbero determinato una maggiore
proliferazione di acari. Alcuni esempi: l'uso dell'aspirapolvere consente di mantenere i
tappeti nella stanza, a differenza di quando venivano sbattuti all'aria aperta; la più
diffusa presenza del riscaldamento nelle abitazioni, ha portato anche in inverno la
temperatura a valori ottimali per lo sviluppo degli acari; umidificazione dell'aria
interna nei micro-ambienti per mantenere valori fra 50 e 70%; ridotta ventilazione per
diminuire la dispersione del calore, con conseguente aumento della umidità. La presenza
degli acari aumenta fra Maggio ed Ottobre e diminuisce fra Dicembre ed Aprile, mentre la
concentrazione degli allergeni è massima fra Luglio e Dicembre e minore fra Aprile e
Maggio. Si ipotizza che il D. pteronyssinus sia più diffuso nelle regioni più fredde ed
umide e che, viceversa, il D. farinae lo sia nelle regioni più calde ed asciutte.
Gli acari tendono a scomparire nelle case di alta montagna quando l'altitudine supera i
1600 metri. Anche nei materassi degli ospedali gli acari sono quasi assenti;
pulizia,disinfezione continua, aerazione e cambio frequente della biancheria sono i
fattori che combattono con più efficacia la presenza degli acari. La dimostrazione che le
feci degli acari sono ricche dell'allergene Der p 1 ha spostato l'attenzione dagli acari
alle feci, ed ha posto il problema di determinare il potere allergizzante dei
microambienti. Infatti difficilmente gli acari e loro detriti sono presenti in sospensione
nell'aria, mentre particelle fecali con diametro intorno a 10 micron si trovano abbastanza
frequentemente disperse nell'aria.
Quando l'aria è in quiete la concentrazione degli allergeni è inferiore a 1
ng/metro-cubo, mentre raggiunge valori di 20 ng/metro-cubo durante i lavori domestici e
ancor più con l'uso dell'aspirapolvere. Dato che esiste una correlazione fra livello
degli aeroallergeni ed incidenza delle manifestazioni allergiche, è importante conoscere
la soglia al di sopra della quale gli allergeni contenuti nella polvere sono in grado di
scatenare la sintomatologia. Da prove eseguite da vari autori è stato stabilito che tale
soglia corrisponde rispettivamente a 2 pg di Der p 1 per g di polvere, che equivale a 0,6
mg di guanina /g di polvere od a 100 acari/g di polvere.
Per ottenere questi valori è fondamentale l'applicazione scrupolosa e costante delle
norme igieniche di prevenzione.
La profilassi ambientale resta il caposaldo della battaglia
all'allergia agli Acari.Un'accurata bonifica igienico-ambientale deve comprendere:
aerazione frequente degli ambienti in modo da ridurre l'umidità al di sotto del 50%;
rimozione accurata della polvere dai pavimenti e dai mobili con aspiratore elettrico
munito di microfilitri che ne evitino la successiva dispersione e panno umido (ottimale
sarebbe l'eliminazione di tappeti e moquette); rimozione di tendaggi pesanti e loro
sostituzione con tende lavabili; eliminazione di altri ricettacoli di povere (scaffali di
libri, giocattoli di péluche, ecc). Non va infine dimenticato che anche gli animali
domestici possono essere portatori di Acari.
Particolare attenzione va posta al letto. Queste le cinque regole d'oro per limitare la
convivenza notturna con i silenziosi "ragnetti":
1) Sostituzione dei materassi e dei cuscini di lana o di piume con altri in gommapiuma o
poliuretano da rinnovare comunque ogni 2-3 anni;
2) Rivestimento dei materassi e dei cuscini con "federe" anti-Acaro in cotone a
trama spessa e pellicola sintetica;
3) Esposizione all'aria e al sole di materassi, cuscini e biancheria;
4) Pulizia della superficie esterna dei materassi e dei cuscini, in particolare in
corrispondenza delle cuciture dove maggiore è la concentrazione degli Acari;
5) Lavaggio frequente, anche bisettimanale, ad alta temperatura di tutta la biancheria da
letto.
Estremamente utile per la bonifica ambientale è l'impiego degli acaricidi e dei
denaturanti degli allergeni degli Acari da spruzzare periodicamente sui materiali di
imbottitura, sui tappeti o sulla moquette. Tra i molti in commercio, ricordiamo per la
loro affidabilità, i prodotti contenenti benzilbenzoato, alcool benzilico e acido
tannico, miscele di tensioattivi e acidi organici naturali. A questi si è aggiunto
recentemente , come insetticida, un derivato sintetico del piretro .
Di discreta utilità risultano i depuratori d'aria con filtri spessi e gli ionizzatori.
Per chi è particolarmente pignolo e vuole verificare l'efficacia del trattamento, ecco
infine un Kit "fai da te" di facile esecuzione in grado di fornire una
valutazione indiretta della concentrazione di Acari rilevando la presenza delle sostanze
azotate da loro escrete . Una striscia di carta reattiva immersa in un campione della
polvere di casa miscelato con un apposito reagente cambia colore in relazione alle diverse
concentrazioni di Acari.
E' il caso di dirlo. Gli strumenti per rendere agli Acari una…vita difficile sono
ormai alla portata di tutti.